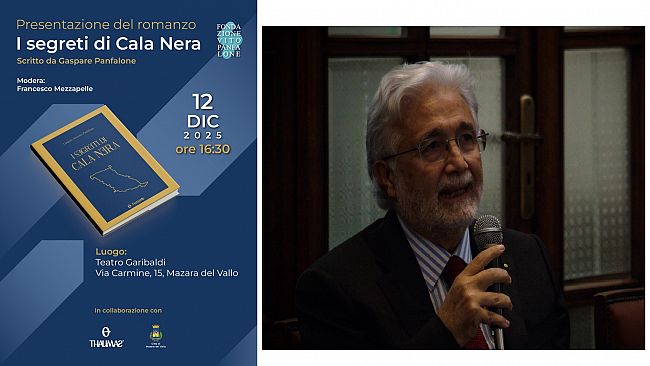di Francesco SCIACCHITANO “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.” Omelia Del Santo Padre Francesco Martedì, 19 marzo 2013 - Solennità di San Giuseppe “Prendersi cura della fragilità delle persone e dei popoli significa custodire la memoria e la speranza; significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità.” Discorso del Santo Padre Francesco al Parlamento Europeo durante la Visita al Parlamento Europeo e al Consiglio d'Europa, 25/11/2014 Vorrei iniziare subito con un invito che è anche una preghiera una preghiera che possiamo fare sempre e in ogni posto e in ogni momento della nostra giornata, una preghiera che non è fatta di parole o di belle intenzioni, una preghiera che è la nostra azione “politica” ogni istante della nostra giornata.
Parafrasando Benedetto Croce.” non possiamo non dirci politici.” e quindi come “politici quotidiani” ascoltiamo l’invito di papa Francesco: Facciamo in modo …” che la responsabilità politica sia vissuta a tutti i livelli come forma più alta di carità”. Già nella Evangeli Gaudium il Papa aveva affermato che “la politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune”. “Prego il Signore – scrive Francesco - che ci regali più politici – e aggiungo io PIU’ CITTADINI - che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri”.
Politici che abbiano cura dei più deboli: gli affamati, i disoccupati, i senza tetto, gli immigrati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, i bambini ancora nel grembo delle madri. Tutti gli sfruttati e quanti la società attuale dello scarto ha trasformato in rifiuti, "avanzi", perché oggi, in questa “economia che uccide”, le “persone – ha detto in una Messa a Santa Marta (1 maggio 2013) - sono meno importanti delle cose che danno profitto a quelli che hanno il potere politico, sociale, economico”.
Il Papa chiede ai politici di cercare non il proprio tornaconto ma la dignità umana. Il pericolo – ha detto ripetutamente – è quello di cadere nella corruzione. Un termine che il Papa amplia ad una dimensione spirituale. Nella Messa per i parlamentari italiani, il 27 marzo 2014, Francesco ha ricordato che il corrotto è chi ha tanto indurito il cuore che non ascolta più la voce di Dio e si è chiuso ai bisogni della gente interessandosi solo alle sue cose e del suo partito. “Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini” che opprimono il popolo con tanti pesi che loro non toccano neanche con un dito.
Il peccatore – rileva il Papa – può sempre pentirsi perché Dio “è misericordioso e ci aspetta tutti”, ma il corrotto è irremovibile perché giustifica se stesso ed è difficile che “riesca a tornare indietro”. Papa Francesco invita i politici, soprattutto quelli cristiani, ad essere coraggiosi: perché la politica – ha ricordato il 30 aprile 2015 incontrando le Comunità di vita cristiana – è una sorta di “martirio quotidiano: cercare il bene comune senza lasciarti corrompere”. “Fare politica è importante” e “si può diventare santo facendo politica”: significa “portare la croce di tanti fallimenti e anche portare la croce di tanti peccati.
Perché nel mondo – sottolinea il Papa - è difficile fare il bene in mezzo alla società senza sporcarsi un poco le mani o il cuore; ma per questo vai a chiedere perdono, chiedi perdono e continua a farlo. Ma che questo non ti scoraggi” a “lottare per una società più giusta e solidale”. Testo tratto da Radio Vaticana/Sergio Centofanti. Ma cosa vuol dire oggi parlare di politica nella comunità? E perché farlo attraverso l’esperienza civica? Proviamo a vedere se c’è un nesso tra queste tre paroline magiche cioè “politica”, “comunità” ed “esperienza civica”.
Per la parola politica ci facciamo aiutare da un grande filosofo greco, infatti il termine nasce dal greco antico politiké, (che attiene alla polis, la città-stato) con sottinteso téchne (l’arte o tecnica) quindi per estensione l’arte che attiene alla città-stato. Dalla stessa radice derivano il sostantivo polites (cittadino) e l’aggettivo politikos (politico). La prima definizione di politica risale infatti ad Aristotele ed è legata all’etimologia del termine; infatti secondo lui politica significava l’amministrazione della “polis” per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano.
Quindi la politica è l’arte di governare le società, ed Aristotele nella “politica” identificò per primo tre forme di governo con le relative degenerazioni: Politeia molto simile alla democrazia ossia il governo in cui a comandare e la massa dove la degenerazione è la corruzione; Oligarchia da oligoi (pochi) ovvero il governo in cui comandano poche persone e non necessariamente i migliori come nel termine aristocrazia; Monarchia da monos (solo) dove c’e un solo uomo al comando.
Altre definizioni si sono aggiunte nel corso dei secoli sugli aspetti peculiari della politica, ne cito alcuni: Max Weber sosteneva che la politica non è che aspirazione al potere e monopolio legittimo dell’uso della forza, per David Easton la politica è invece l’allocazione di valori imperativi (cioè di decisioni) nell’ambito di una comunità, per Giovanni Sartori la politica è la sfera delle decisioni collettive sovrane. In definitiva la politica riguarda tutti i soggetti facenti parte di una società, e non solamente chi fa politica attiva, cioè chi opera dentro le strutture deputate a determinarla, ossia i partiti ed i movimenti.
E’ l’occuparsi in qualche modo di come viene gestito lo stato e le sue diramazioni territoriali che fanno si che tutta la comunità si occupa di politica, anche chi subisce gli effetti negativi di chi materialmente è istituzionalmente investito di questo potere e scende in piazza a protestare, o chi si preoccupa del bene pubblico raccogliendo semplicemente una carta da terra e la mette nel cestino, o chi evita di sprecare l’acqua fa un azione politica. Quindi il primo nesso lo abbiamo trovato tra la parola politica e comunità che chiaramente vanno a braccetto e sono inscindibili possiamo quindi tranquillamente dire che la politica viene agita da tutta la comunità.
Adesso vediamo cosa c’entra l’esperienza civica, nel secolo appena trascorso l’arte della politica è diventata anche laboratorio pratico delle teorie politiche. Si sono sviluppati, infatti, una moltitudine di sistemi diversi di gestire la cosa pubblica. Accanto alle monarchie dei primi anni del novecento si svilupparono le prime democrazie borghesi, e contemporaneamente i primi esperimenti di applicazione pratica del socialismo, la maggior parte dei quali purtroppo sfociati in sistemi oppressivi.
Nella prima metà del secolo a queste forme si affiancarono i totalitarismi ed autoritarismi di destra, prodotti dalla crisi delle fragili democrazie. Negli ultimi anni la politica è andata via via trasformandosi includendo come soggetto la cosiddetta società civile, fatta di movimenti d’opinione che cercano di sottrarla all’astrazione in cui è stata sempre confinata: la politica si fa globale e nella coscienza di molti si delinea come stato in costante divenire delle relazioni sociali ed economiche.
Ad esempio uno degli strumenti d’intervento della società civile nell’azione politica istituzionale sono apparsi sempre più spesso i referendum di iniziativa popolare sia in ambito nazionale, regionale o locale. Ma è evidente come in questo ultimo periodo l’esperienza civica abbia varcato i confini nazionali, un esempio per tutti e Greta Thumberg la diciassettenne attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico che in pochissimo tempo, cioè dal 20 agosto del 2018, data in cui ha iniziato la sua protesta silenziosa, seduta davanti al parlamento del suo paese ogni giorno invece di andare a scuola.
Ha originato un movimento studentesco mondiale “Friday for future” con numeri spaventosi, ha praticamente contaminato tutto il pianeta, su un tema chiaramente di vitale importanza che riguarda tutti noi e la sopravvivenza stessa della casa che abitiamo. Detto questo è molto importante capire quali sono gli elementi sociali e personali che concorrono a determinare la partecipazione delle persone? E voglio citare il contributo di uno studioso riconosciuto, che si è occupato a lungo di questo tema, David H.
Smith, che nel lontano 1975 in una delle sue tante pubblicazioni sosteneva che: «L’azione volontaria è l’azione di individui, collettività, o di aggregati in quanto caratterizzati primariamente dalla ricerca di benefici psichici (ad esempio, senso di appartenenza, di stima, realizzazione di sé) e dall’essere svolta su basi discrezionali [non essendo determinata primariamente da fattori biosociali (o da pulsioni psicologiche nelle loro forme socializzate), fattori coercitivi (ovvero obblighi imposti attraverso la minaccia della forza), o da remunerazione diretta (tramite erogazione diretta di denaro o di altri benefici di natura economica).
È una definizione ampia, flessibile e che può essere accolta anche a distanza di anni. Gli elementi costitutivi della definizione di “azione volontaria” sono tre: gli attori: l’azione volontaria può essere realizzata da individui, collettività o comunità locali; la finalità: è caratterizzata da attività che rafforzano il senso di appartenenza, di stima e di realizzazione di sé; la natura: attività che non sono svolte per necessità, o per imposizione, in base ad obblighi di affiliazione dipendenti dalla famiglia di nascita, o per un compenso in denaro.
Ma cosa può aiutare il cittadino ad avere cura della cosa pubblica? Quali percorsi ed esperienze formative portano il cittadino a scegliere di spendere il proprio tempo libero all’interno di un progetto politico di natura civica? A tal proposito vi racconto la storia di una delle materie scolastiche che più ho amato. C’era una volta l’Educazione Civica…. Comincia così la storia di una disciplina scolastica, la cenerentola della scuola italiana, nata nella sala dei Parlamenti del Castello Ursino di Catania, ai piedi dell’Etna e sul mare Jonio e che, dopo tanti anni di solitudine e di trascuratezza, forse, e lo spero ardentemente, potrà indossare nuovamente l’abito della festa e ritornare a contare come disciplina scolastica ed essere oggetto di valutazione curriculare.
Da questo anno scolastico, in tutte le classi, dalla prima elementare alla quinta superiore: non ci sarà un’ora in più di scuola, ma il voto in pagella per una disciplina trasversale che coinvolge tutti gli insegnamenti. Bentornata Educazione Civica e la piccola “Cenerentola”, indosserà un abito moderno “desigual” che scambia la forma di disciplina scolastica in azione formativa trasversale valutata con un voto che stimola tra gli studenti all’impegno di studio della Costituzione, per conoscere le leggi e gli ordinamenti dello Stato e dell’Europa, ad operare negli ambienti digitali e ad agire da cittadini attivi e responsabili, mettendo in pratica il senso civico che costituisce l’obiettivo e la competenza trasversale dell’Educazione Civica.
L’educazione alla cittadinanza intende presentarsi oggi con le caratteristiche del mondo “digitale” ed il compito di: “Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali”. La nuova Educazione civica ha il compito di “fornire norme comportamentali nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali”. In attuazione della proposta di legge già deliberata alla Camera, la «conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni comunitarie» sarà un «insegnamento trasversale», ed ogni scuola ricaverà 33 ore annuali per insegnare i «principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona», prendendo ore un po’ da tutte le materie, come il Consiglio di Istituto riterrà più utile.
L’insegnamento potrà essere anche affidato a più insegnanti in contitolarità, ma ci sarà un coordinatore. Il Coordinatore dell’Educazione Civica, (forse il Referente per i progetti di legalità o il Docente di Diritto dell’organico funzionale) sarà il padre e o la madre adottiva della piccola Cenerentola e dovrà farsi carico di organizzare le ore, assicurare che in tutte le classi si svolgano questi momenti d’istruzione e di formazione e che tutti gli studenti acquisiscano le competenze di cittadinanza che oltre ad essere “attiva e responsabile” diventa anche “digitale”, secondo le indicazioni del Decalogo approvato dal MIUR nel gennaio dello scorso anno: un sillabo che ha lo scopo di inquadrare il corpus di temi e contenuti che sono alla base dello sviluppo di una piena cittadinanza digitale degli studenti attraverso il percorso educativo.
Quindi la legge 92 del 20 agosto 2019, entrata in vigore il 5 settembre dello stesso anno istituisce a partire dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado materia che prenderà il nome di “Educazione alla cittadinanza attiva”. Devo dire che un pò mi emoziona, parlarvi di questo, perché ricordo il mio primo libro di Educazione Civica alle medie “Libertà è partecipare”, ricordo ancora l’immagine della copertina, il buon odore che facevano quei fogli che ho letto e riletto tante volte, e che hanno dato origine al mio impegno politico, che cerco di portare avanti nella mia quotidianità, in famiglia come nel lavoro o nel volontariato, e tutto questo grazie alle pagine di quel libro.
Poi più avanti ho scoperto che il titolo di quel libro non era altro che il titolo di una bellissima canzone di Giorgio Gaber autore che ho amato e che amo tantissimo, e voglio citare alcuni versi di questa canzone che mi hanno accompagnato sin dalla mia adolescenza, e che stanno alla base del mio concetto di partecipazione alla vita politica della porzione di mondo che abito. La libertà non è star sopra un albero Non è neanche un gesto o un'invenzione La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione La libertà non è star sopra un albero Non è neanche il volo di un moscone La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione.
Si perché uno dei concetti più alti, uno dei valori imprescindibili dell’uomo, cioè quello della libertà, è proprio come dice Gaber, libertà è partecipazione, è lo stare con gli altri, è il condividere assieme sogni progetti, è il lavorare per il bene comune, per il bene di tutti, e non finirò mai di gridarlo a tutte le persone che incontro, tutti noi abbiamo questa che per me è una vera è propria vocazione, si io mi sento chiamato ad occuparmi della mia famiglia, ma anche delle famiglie del mio condominio, sono chiamato ad occuparmi del mio quartiere, della mia città, del mio paese, del mondo intero, e cosi tutti, nelle forme che ognuno ritiene opportune, non possiamo non donare i nostri talenti, le nostre esperienze, le nostre intuizioni agli altri.
Scusate l’enfasi con cui scrivo ma è perché credo fermamente in questi valori e vorrei che ognuno si assumesse la responsabilità di un pezzettino di mondo e che lo facessimo tutti assieme per ritornare “a quote più normali” per citare un’altro dei miei autori preferiti, il maestro Franco Battiato, che preparassimo un mondo più vivibile per le future generazioni e per la sopravvivenza stessa del pianeta. Ma adesso andiamo ai giorni nostri in questo tempo che abbiamo vissuto nel periodo del lockdown considerato da molti una ripartenza.
Spero che il reset che il virus ci ha costretto a fare possa servire ad eliminare tutte le tossine di cui purtroppo siamo stati impregnati e vedere il mondo con colori nuovi, che sono i colori della generatività, della sostenibilità e dell’abitare una casa un pò migliore di come l’abbiamo trovata. La partecipazione, come è stato negli occhi di tutti è centrale soprattutto in periodi di emergenza come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo perché consente di creare senso di comunità e appartenenza e serve anche ad orientare l’azione pubblica sulle reali esigenze e domande delle persone.
In questo periodo abbiamo visto molte esperienze, nate e diffuse attraverso la Rete, dalle raccolte fondi al supporto psicologico, dai flash mob allo scambio di doni a distanza, come offerta di arte e cultura per vivere meglio questi momenti o attività di formazione. Molte aziende poi hanno sviluppato progetti online di utilità quotidiana, come strumenti per vedere dove c’è meno fila o dove si possono trovare le mascherine. Senza dimenticare che la rete permette una partecipazione a livello mondiale”.
Nessuno si salva da solo è stato fortunatamente lo slogan di questo momento storico. Per concludere voglio raccontarvi un esempio virtuoso di partecipazione, realizzato nel comune di Torino, che già nel gennaio del 2016, adottava il suo primo “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. Non contenta ad appena quattro anni dall’approvazione del Regolamento n. 375 sui beni comuni, la Città di Torino ha avvertito la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento per il governo dei beni comuni urbani, che è stato adottato in Consiglio Comunale con deliberazione del 2 dicembre 2019.
Il nuovo Regolamento, il n. 391, è un avanzamento del precedente, frutto della necessità di ridefinire con maggiore semplicità e chiarezza alcuni aspetti procedurali, allo scopo di snellire i tempi e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica per fornire adeguata risposta alle sollecitazioni provenienti dalle comunità locali, che si confermano il centro nevralgico anche nella nuova disciplina. Cambia radicalmente la denominazione di “cittadini attivi”, sostituita da quella di “soggetti civici”, definiti come «tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l’individuazione di beni comuni e ne organizzano le attività di governo, rigenerazione, cura e gestione».
Dall’insieme dei soggetti civici che si riconoscono e si organizzano per l’autogoverno di un bene comune sorge quella che viene denominata una comunità di riferimento che ne è, in sintesi, l’elemento principale di aggregazione. Viene dato grande rilievo alla formazione per la diffusione della cultura dei Beni comuni e dei valori del Regolamento, che è concepita come un processo di apprendimento, rivolto tanto alle comunità di riferimento quanto ai dipendenti e amministratori della Città.
Nascono nuovi negozi giuridici al fianco dei Patti di collaborazione introducendo una distinzione netta fra forme di governo condiviso e forme di auto-governo, dove le prime prevedono il coinvolgimento tanto dei soggetti civici che dell’Amministrazione e si concretizzano nei tradizionali Patti di collaborazione, mentre le seconde implicano un’azione autonoma da parte dei soli soggetti civici e si concretizzano in usi civici e collettivi urbani e in gestioni collettive urbane. Gli aspetti più innovativi del nuovo Regolamento sono contenuti, senza dubbio, nella parte che disciplina l’auto-governo dei beni comuni.
Si prevede che, con atto formale del Comune, si possa mettere un bene a disposizione di una comunità di riferimento a condizione che questa si doti di una carta di auto-governo per disciplinare le modalità con cui utilizzare il bene messo a sua disposizione. Quest’ultimo diviene, così, oggetto di uso civico e collettivo urbano. Ed infine, si prevede l’istituto della Fondazione Beni Comuni, che viene a costituirsi quando la Città, verificata la presenza di una comunità di riferimento, ovvero su iniziativa di una comunità stessa, decide di affidarle in usufrutto di breve durata determinati beni comuni urbani.
Frattanto, il bene resta patrimonio della Città che si impegna a non alienarlo, e al termine del periodo di usufrutto, il bene può essere conferito in via definitiva alla Fondazione. Chiaramente lo Statuto della Fondazione dovrà, prevedere il rispetto di alcuni principi generali come la presenza di organi decisionali democraticamente eletti, un termine per le cariche, la garanzia dell’accessibilità agli spazi e ai servizi resi in forma libera e gratuita o, tutt’al più, a prezzi agevolati.
La sperimentazione sociale che ha avuto luogo a Torino negli ultimi anni nel contesto del governo dei Beni comuni giustifica le esigenze innovative che hanno spinto l’amministrazione a ripensare, dopo così pochi anni dalla sua prima adozione, la disciplina dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni urbani. D’altra parte è il tipo di strumento, il regolamento comunale, che presta il fianco a innovazioni e adattamenti ai contesti territoriali di riferimento, in piena adesione allo spirito della sussidiarietà; motivo per cui si è dimostrato tanto prolifico nella sua diffusione sul territorio del nostro Paese.
Voglio concludere questo mio breve scritto con la frase che più mi ha colpito durante il periodo di confinamento sociale dovuto al Covid 19, una frase apparsa sui social che recita pressapoco così: “Chi può metta, chi non può prenda”. Frase che in tanti ne hanno reclamato la paternità ma che pochissimi conoscono la storia di questa frase, enunciata da uno dei più brillanti medici che il sud Italia ha avuto nella sua storia, sto parlando del “medico dei poveri” Giuseppe Moscati, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987.
La rubrica “Le ultime della sera” è a cura della Redazione Amici di Penna. Per contatti, suggerimenti, articoli e altro scrivete a: amicidipenna2020@gmail.com