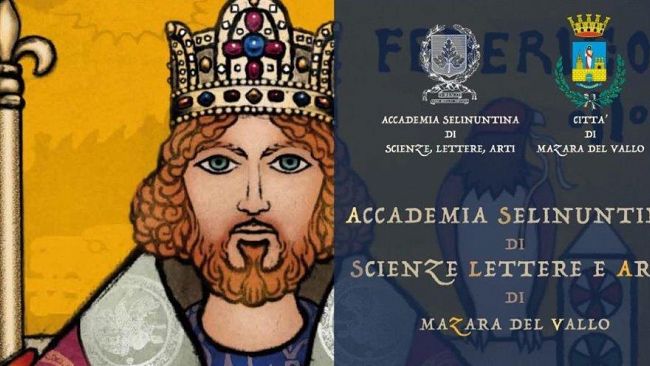Ricerche sul territorio di Mazara e nelle sue viscere, monumentalità nascoste e venute alla luce, i viaggi nell’entroterra siciliano, artisti e personaggi che animarono la storia della città in epoche remote, le leggende che accompagnarono piccoli e grandi, uomini e donne di una città che è riemersa negli anni, poco alla volta. E poi,la fame di sapere, il bisogno di seminare cultura ed ecco, tra storia e leggenda che nel 1958 è nata a Mazara l’Accademia Selinuntina di Scienze Lettere e Arti ad opera dello scomparso preside Gianni Di Stefano.
Scomparso“ l’organizzatore di cultura mazarese”, l’Accademia si è fermata per anni, sembrava sepolta, affioravano soltanto lontani ricordi, fino a quando, per opera di alcuni volontari, ha ripreso nel 2009 la sua instancabile attività con nuovi statuti ma innanzitutto ricorda con grande affetto e indiscussa stima il rifondatore dell’Accademia stessa e il poligrafo che ha reso particolarmente celebre il sodalizio con la istituzione prima del “Premio Sélinon” e la pubblicazione, poi, degli “Annali Selinuntini”, che restano delle preziose testimonianze.
Il “Premio Sélinon”, voluto ed organizzato dal professore Gianni Di Stefano, ha richiamato in città personalità di spicco del mondo culturale ed accademico perché destinato a personalità della cultura che avessero contribuito notevolmente alla migliore conoscenza della civiltà della Sicilia o ne abbia testimoniato, con apporto originale, i peculiari valori ma ha voluto essere anche una testimonianza di gratitudine per chi, nato sotto altri cieli, aveva dedicato tanta parte della sua vita laboriosa alla Sicilia.
Nel 1980 è stato premiato Wolfang Krónig, storico dell'Arte, Professore emerito dell'Università di Kòln (Colonia); nel 1981 Bruno Lavagnini, ellenista, Professore emerito dell'Università di Palermo, Presidente dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici; nel 1982 Georges Vallet, Archeologo, Professore dell'Università di Parigi, allora Direttore della Scuola francese di Roma; 1983 Eugenio Manni, Storico dell'età antica, Professore emerito dell'Università di Palermo, Presidente dell'Istituto siciliano di storia antica; 1984 Luigi Bernabò-Brea, paletnologo, già docente di paletnologia nell'Università di Palermo, già Soprintendente alle antichità della Sicilia orientale; 1985 Sabatino Moscati, fenicista, Professore dell'Università "La Sapienza" di Roma, Presidente dell'Istituto per la civiltà fenicia e punica; 1986 Francesco Gabrieli, arabista, Professore emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma; 1987 Antonio Ferrua S.I., epigrafista ed archeologo, Professore emerito e già Rettore del Pontifìcio Istituto di archeologia cristiana; 1988 Ettore Paratore, latinista, Professore emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Dopo quell’anno, che ebbe un notevole riscontro anche a livello nazionale per la presenza di Ettore Paratore, traduttore di importanti opere dal latino, il professore Di Stefano uscì dalla scena e con lui anche il “Premio Selinon” come gli “Annali” che oggi sono stati sostituiti dai “Quaderni dell’Emporion”, un progetto nato con l’obiettivo di promuovere il territorio dell’antico Emporion Selinuntino, qual è stata appunto Mazara. La prima pubblicazione ha riguardato un saggio sullo stemma civico della città, inteso come “carta d’identità di un luogo” quindi documento sintetico identificativo e certo, e una breve opera l’”Elcethium”, saggio storico-archeologico inedito del dott.
Filippo Napoli, autore della Storia di Mazara. Qualche anno fa, è stato celebrato Tommaso Sciacca, un pittore mazarese del XVIII secolo che operò in diverse città italiane e la cui qualità artistica, già riconosciuta da vari autori a lui coevi, si è dipanata nel tempo. La pubblicazione dell’opera, scritta dalla professoressa Lorena Sferlazzo, non si è limitata però solo a riconsegnare il pittore alla sua dignità storica, infatti, con i proventi della vendita d’essa si è voluto contestualmente intervenire al restauro di una delle opere dello Sciacca presenti in Mazara del Vallo, nella chiesa di San Michele Arcangelo nel 1766 .
Adesso l’Accademia Selinuntina di Scienze Lettere ed Arti “raccoglie in un sodalizio quanti intendono collaborare per testimoniare la cultura siciliana ed il contributo della Sicilia alla civiltà mediterranea”, come si legge fra le pagine del suo blog. Ma perché si chiama Accademia Selinuntina? Perché gli umanisti mazaresi di un tempo amarono identificare Mazara con l’antica Selinunte. E selinuntino si disse nella sua “Topographia inclytae civitatis Mazariae” l’umanista mazarese Gian Giacomo Adria scrivendo: “Selinis Inclyta urbs mea dulcis patria”.
Lo stesso Adria, altrove, aveva detto la città natale “Docta Selinis” e “Formosa Selinis” e gli esempi potrebbero continuare. Questi umanisti, secondo l’Adria, solevano recarsi periodicamente a Miragliano, lungo la riva sinistra del Mazaro, là dove sgorgava una fonte di dolci acque che essi chiamavano Ippocrène, a somiglianza di quella che, secondo il mito, era sgorgata in Beozia sotto gli zoccoli del cavallo Pegaso. Oggi, Presidente dell’Accademia è il prof. Don Pietro Pisciotta, vice presidente l’Architetto e storico Mario Tumbiolo.
Salvatore Giacalone