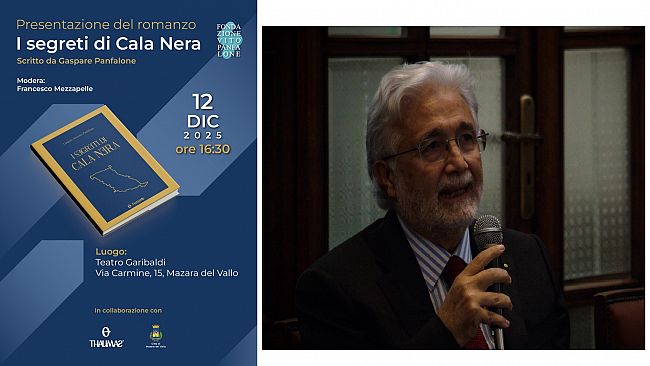Trentatré anni fa il giudice trapanese Alberto Giacomelli fu freddato dal piombo di Cosa Nostra. Era il 14 settembre del 1988 quando il corpo del magistrato di sessantanove anni, in pensione da quindici mesi, fu ritrovato sulla strada provinciale che conduce a Trapani, accanto alla sua Fiat Panda. Non si era quasi mai occupato di vicende di mafia, era stato un magistrato ordinario, quieto e tranquillo. Un giudice “scarsamente aggiornato”, lo definì qualche collega. Nel 1987 decise di appendere la toga al chiodo e andarsene in pensione.
Quel giudice moderato e innocuo, anche se oggi è un perfetto sconosciuto per moltissimi, nel 1985 compì un gesto che, se non lo vogliamo definire eroico, possiamo quantomeno qualificarlo come coraggioso e onorevole: egli pose la sua firma per far sequestrare una casa di Mazara intestata a Gaetano Riina fratello di Totò Riina. Una firma che lo condannò a morte, perché il capo dei capi non perdonava nulla, tantomeno un torto alla sua famiglia (tratto da “Alberto Giacomelli: il coraggio di una firma contro Riina” di Serena Verrecchia).
Il commando di morte partì alle otto di mattina del 14 settembre per raggiungere il giudice sulla provinciale, costringerlo a frenare e concedergli solo il tempo di rendersi conto che la sua vita era giunta al termine. Un uomo che non si aspettava di morire, un magistrato che non aveva sfidato a volto aperto Cosa Nostra, ma un servitore dello Stato che quando il destino lo aveva posto dinanzi ad una prova di coraggio non si era tirato indietro. Non aveva badato ai nomi, Alberto Giacomelli. Aveva compiuto il suo dovere quando era stato chiamato a farlo e per questo fu ammazzato.
Nel 1992, invece, l’allora dirigente del commissariato di Polizia di Mazara, Rino Germanà, sfuggì ai Kalashnikov dei killer più spietati della mafia siciliana. Era sul lungomare di Tonnarella quando Rino Germanà fu inseguito da un’auto guidata da Matteo Messina Denaro. A bordo anche due pericolosissimi killer, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano, che lo misero nel mirino delle loro armi. Doveva morire Germanà che si stava occupando dei rapporti tra mafia e politica, che indagava sui soldi sporchi della mafia, sulle banche controllate da Cosa nostra e dove i Messina Denaro avevano riciclato e riciclavano i loro milioni sporchi del sangue di tanti morti ammazzati. L’arma si inceppò, i killer continuarono a sparare fin quando capirono che non potevano più colpire il bravo investigatore.
Le indagini di Germanà finirono in processi nei quali ci furono condanne eccellenti per mafiosi e colletti bianchi. Finirono anche dentro il processo contro il senatore D’Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, indicato come uno dei maggiori “favoreggiatori” dei Messina Denaro, del padre Ciccio e del figlio Matteo, suoi campieri. Proprio recentemente, il 20 luglio di quest’anno, la corte d'Appello di Palermo ha condannato a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa il senatore D’Alì.
D’Alì era a capo di una famosa famiglia di banchieri. La Banca Sicula era cosa loro e fu assorbita negli anni ’90 dalla Banca Commerciale. Germanà indagava sulla Banca Sicula. Quando un giorno il commissario fu sentito in un processo, rispose così a una specifica domanda: “Indagavo sulla Banca Sicula e poi…mi hanno sparato”. Il PM chiese se quella sequenza secondo lui era casuale. “No signor Pubblico Ministero, non lo so, so solo che indagavo sulla Banca Sicula e poi mi hanno sparato” (tratto da “Il 14 settembre insanguinato dalla mafia” di Rino Giacalone (AntimafiaDuemila).
di Domenico RIPA
La rubrica “Le ultime della sera” è a cura della Redazione Amici di Penna.
Per contatti, suggerimenti, articoli e altro scrivete a: amicidipenna2020@gmail.com